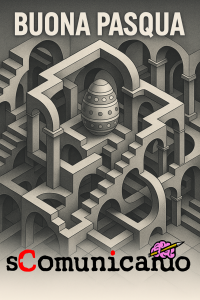Il grande sogno .. il 68 dei sentimenti e dell’impegno, un film lucido e ben disegnato tra ricordo e utopia. Nei ricordi di Placido anche i morti di Avola.

La trama: Nel 1968, Nicola è un bel giovane pugliese che fa il poliziotto ma sogna di fare l’attore, e si trova a dover fare l’infiltrato nel mondo studentesco in forte fermento. All’universitàincontra Laura una ragazza della buona borghesia cattolica, brillante e appassionata studentessa che sogna un mondo senza ingiustizie, e Libero, uno studente operaio, leader del movimento studentesco che sogna la rivoluzione. Tra i tre nascono sentimenti e forti passioni e Laura – sedotta da entrambi – dovràscegliere chi dei due amare. Anche i fratelli minori di Laura, Giulio e Andrea, sentendosi coinvolti dal clima di contestazione, portano lo scompiglio in famiglia. …..
Certamente un film da vedere, non è un documentario, ed offre, anche, in sala la possibilitàdi vedere o rivedere amici, “nostalgici e reduciâ€Â, rimane l’occasione per definire uno spaccato storico, che introduce al “settantasetteâ€Â, agli anni di piombo, allo stragismo di stato, ma anche alle riflessioni “ a caldo†che fece Pier Paolo Pisolini, insomma si può vedere, si può dibattere, fa discutere… da far vedere a scuola, per non far perdere memorie e testimonianze…
In programmazione anche all’Altercinema –palacultura – a Gliaca di Piraino
.
La critica di Valentina D’Amico ( www.movipalyer.it)ÂÂ
Nonostante le polemiche che influenzeranno inevitabilmente le opinioni sul film, possiamo sfatare ogni dubbio affermando che, a nostro giudizio, Il grande sogno è un film che unisce ricostruzione storica a dramma borghese, suggestive scene di massa a scene calde, incluso un nudo frontale di Jasmine Trinca.Il filtro del passato serve ancora per dirci qualcosa sul presente che viviamo? Ne è convinto Michele Placido che, dopo il riuscito Del perduto amore, torna a scavare nel proprio passato per raccontarci un pezzo della nostra storia. Dalla sperduta Lucania degli anni ’50 veniamo improvvisamente catapultati nel 1968 romano, tra occupazioni studentesche, attivismo politico, proteste contro la guerra in Vietnam e scontri di piazza tra studenti e polizia (tra i quali il più celebre, quello di Valle Giulia, da cui Pier Paolo Pasolini prese le distanze con una polemica composizione poetica). Da Bertolucci ad Ang Lee, molti autori hanno sentito e sentono il bisogno di raccontare il punto di svolta del 1968, momento chiave vissuto sulla propria pelle o solo auspicato da lontano. Per Placido l’esigenza è doppiamente più forte visto che il 1968 coincide con l’abbandono di un lavoro sicuro in polizia per tentare la carriera dell’attore. A incarnare il regista nel film è il corrucciato Riccardo Scamarcio che si produce in una discreta imitazione del sanguigno Placido senza riuscire a scrollarsi di dosso del tutto quel finto-stupito candore che ultimamente contraddistingue i personaggi da lui interpretati, portato stucchevolmente all’eccesso da Costa-Gavras nel recente Verso l’Eden.
Nonostante le polemiche che hanno preceduto e accompagneranno ancora per un bel pezzo Il grande sogno – polemiche ulteriormente alimentate dal carattere iracondo di Placido – influenzando inevitabilmente le opinioni sul film, possiamo sfatare ogni dubbio affermando che, a nostro giudizio, la pellicola in questione è un discreto lavoro che unisce ricostruzione storica a dramma borghese, suggestive scene di massa a momenti di intimitàsessuale, incluso un nudo frontale della pudica Jasmine Trinca. Che le prime a mettere in pratica i principi della liberazione sessuale fossero le ragazze di buona famiglia e di educazione cattolica giàlo sospettavamo, ma mostrarci tale paradigma esplicitamente espone il film a rischio ‘luogo comune’ e i momenti del genere abbondano soprattutto nella rappresentazione delle relazioni che intercorrono all’interno della famiglia borghese a cui il personaggio della Trinca appartiene. Decisamente più interessante la ricostruzione delle lotte sessantottine all’interno e all’esterno dell’università, ricostruzione incentrata sulla presa di coscienza degli studenti di estrazione borghese, ma anche su quella di un giovane agente di polizia appassionato di teatro e non di politica. Placido, che quando vuole sa essere un buon regista e Romanzo Criminale ne è la conferma, filma con eleganza e un pizzico di autocompiaciuto manierismo concitate scene di scontri tra studenti e polizia in cui il colore e il bianco e nero ‘old style’ si alternano a ricreare il look di un’epoca. Ovviamente rimestare nel passato facendo affidamento principalmente sulla propria memoria è sempre rischioso e Placido mette le mani avanti sottolineando come il suo film, più che un affresco storico, vuole essere un diario privato, una ricostruzione della sua gioventù non priva di qualche anacronismo, ma sincera e appassionata. Se la passione non manca, talvolta è l’originalitàa difettare. Il film non si sforza di dirci niente di nuovo su un mondo che ci ha profondamente influenzati, ma di cui la nostra generazione ha sentito parlare solo a posteriori, spesso in maniera critica, vista la degenerazione dei movimenti di contestazione dell’epoca culminata negli Anni di Piombo e nel Brigatismo. Gli eventi topici del ’68, dalla morte di Che Guevara alle lotte contadine in Sicilia, fino alla manifestazione contro Nixon del 1969, vengono accennati senza alcun approfondimento né incidono in modo specifico sulla maturazione ideologica dei protagonisti del triangolo sentimentale messo in scena da Placido. A dirla tutta all’interno dello stesso triangolo vi è un certo sbilanciamento perché se dal canto suo la Trinca, in quanto donna, volitiva e talentuosa, ruba spesso la scena ai due colleghi, e Scamarcio viene necessariamente protetto grazie al ruolo che gli è stato assegnato, Luca Argentero si dimostra l’anello debole della catena e stavolta non per colpa sua…… 
Regia: Michele Placido Cast: Riccardo Scamarcio (Nicola)Jasmine Trinca (Laura)Luca Argentero (Libero)Massimo Popolizio (Domenico)Alessandra Acciai (Francesca)Dajana Roncione (Isabella)Federica Vincenti (Rosa)Marco Brenno (Giulio)Marco Iermanò (Andrea)Laura Morante (Maddalena)Silvio Orlando (Colonnello) Soggetto: Doriana Leondeff, Angelo Pasquini, Michele Placido Sceneggiatura: Doriana Leondeff, Angelo Pasquini, Michele Placido Montaggio: Consuelo Catucci Scenografia: Francesco Frigeri Fotografia: Arnaldo Catinari Musiche: Nicola Piovani Costumi: Claudio Cordaro
Altre Critiche
Dalle note di regia: “Il ’68 che racconto è quello della mia conversione: quella di un ventenne, meridionale, poliziotto, che dopo aver manganellato gli studenti universitari capisce la loro protesta e passa dall’altra parte della barricata. E’ il film della mia vita, è un romanzo di formazione trasposto su pellicola, è l’evoluzione di un percorso che intreccia destini individuali e collettivi, è una storia di grandi sentimenti e della realizzazione di un sogno, un ‘grande’ sogno, che ha accomunato generazioni di giovani in tutto il mondo.”
“Una storia di vocazione e di maturazione che Placido affida, sullo schermo, a un bravo Riccardo Scamarcio e che racconta con più di un omaggio (di stile e di regia) a uno dei suoi primi «maestri» cinematografici, Marco Bellocchio. Dove quell’ insegnamento viene meno è nel raccontare e filmare quello che Placido/Scamarcio incontra nella Roma del Sessantotto e che si chiamano Laura, borghese di famiglia cattolica affidata a Jasmine Trinca, e Libero, proletario marxista cui dàil suo volto Luca Argentero. Perché se il film funziona nel ripercorrere il percorso umano di Nicola, finisce per diventare freddo e troppo programmatico nel ricostruire il «grande sogno» che il Sessantotto rappresentò. E non perché dialoghi o scene siano falsi (a parte la ricostruzione degli scontri di Avola, davvero brutta) ma perché tutto è troppo lineare e programmatico, senza sfumature o esitazioni, e soprattutto eccessivamente rappresentativo, dalla copertina di ‘Lettera a una professoressa’ ai discorsi sul salto di qualità. La vita, anche per i più militanti, era (fortunatamente) un po’ più complessa e complicata e per questo appassionava, mentre sullo schermo i pochi momenti di veritàe passione finiscono per ridursi ai primi passi di attore di Nicola e alle angosce borghesi della famiglia di Laura.” (Paolo Mereghetti, ‘Corriere della Sera’, 10 settembre 2009) ità. La vita, anche per i più militanti, era (fortunatamente) un po’ più complessa e complicata e per questo appassionava, mentre sullo schermo i pochi momenti di veritàe passione finiscono per ridursi ai primi passi di attore di Nicola e alle angosce borghesi della famiglia di Laura.” (Paolo Mereghetti, ‘Corriere della Sera’, 10 settembre 2009) 
“Il ’68 visto da uno che stava dalla parte dei poliziotti, almeno all’inizio: Michele Placido, arrivato a Roma dalla nativa Puglia per fare il celerino. La contestazione raccontata come una grande fiction tv, con linguaggio semplice, stereotipi di ogni genere, personaggi e conflitti ben delineati e senza sfumature (il poliziotto Riccardo Scamarcio; il leaderino Luca Argentero, fuori ruolo; la studentessa cattolica Jasmine Trinca). Un periodo di grandi cambiamenti che sullo schermo va dall’inverno ’67 alla fine del ’69 senza nemmeno un accenno alla strage di piazza Fontana, a Milano, che il 12 dicembre 1969 diede il via a tutt’altra stagione. Altro che polemiche: ‘Il grande sogno’ di Michele Placido è un affresco nazionalpopolare fatto per piacere a tutti senza accontentare davvero forse nessuno. Un film di formula, spesso tentato dalla commedia, che traduce in figure e psicologie molto riconoscibili un’epoca carica di novitàe trasgressioni.” (Fabio Ferzetti, ‘Il Messaggero’, 10 settembre 2009)
“Il caliente Michele, regista alterno come pochi altri, non ha inteso esprimere la parola definitiva sul Sessantotto bensì trasporre sullo schermo un amarcord di formazione, anzi di conversione. (…) La prima parte di ‘Il grande sogno’ non è affatto male, perché Placido e i volenterosi attori colgono con vivacitàcerte atmosfere del movimento, alcuni tic ricorrenti, l’auto-educazione cinéfila, l’eco ambientale di occupazioni e manifestazioni, l’energia pura che prorompe senza differenze di tono dai grandi gesti alle bizzarre performance, dalle pubbliche genialitàalle private ottusitàe viceversa. In questo senso si può giàregistrare come Scamarcio resti molto aderente allo spaesamento dell’alter ego di Placido, Trinca risulti sin troppo giusta nella parte più odiosa di suffragetta cattolica e Argentero stupisca ancora non solo per avvenenza, ma soprattutto per credibilitàe scioltezza. Purtroppo man mano che il plot (…) rievoca l’evolversi del movimento (…) il tutto si spappola in una sorta di bignamino gradevole ma inerte. Se poi avràavuto o meno ragione Pasolini nel preferire i poliziotti ai figli di papà, non chiedetelo a Placido che ha giài suoi problemi nel tenersi in equilibrio tra la divulgazione, la nostalgia, l’apologia e un «piccolo» dubbio (il terrorismo incombe).” (Valerio Caprara, ‘Il Mattino’, 10 settembre 2009)di bignamino gradevole ma inerte. Se poi avràavuto o meno ragione Pasolini nel preferire i poliziotti ai figli di papà, non chiedetelo a Placido che ha giài suoi problemi nel tenersi in equilibrio tra la divulgazione, la nostalgia, l’apologia e un «piccolo» dubbio (il terrorismo incombe).” (Valerio Caprara, ‘Il Mattino’, 10 settembre 2009)
“Qui non ci sono ‘Dreamers’, il ’68 di Placido-Scamarcio è un’assenza, il riflesso di un’esperienza, e nonostante il punto di vista dichiarato si percepisce, disturbante, l’annullamento della temperatura politico-emotiva di quei giorni. Non c’è l’odore del ’68, non la sua carica assordante e inebriante, il passaggio di stagione, la frattura tremenda tra prima e dopo, non il presente che decompone ancora con rabbia poteri, sevizie, inciviltà. Non è passato mai, lui sì passatista, che prova a seppellire quei giorni, assumendoli bonariamente come folklore. E questo al di làdelle buone, oneste intenzioni di Placido, che quando uscì ‘Dreamers’, pensò di rinunciare al suo film, ma poi andò perché era ‘diverso dall’estetismo geniale’ di Bernardo Bertolucci. Quell’estetismo geniale eravamo noi, si tratta di luce, di prospettive, di gusti, più di Filmstudio che di Nuovo Olimpia. Più paesaggi mentali che ricostruzioni sulle scalinate di Valle Giulia. Ma a parte questo, ‘Il grande sogno’ è un film che lievita commuovente làdove intercetta la memoria personale di Placido, come quando Scamarcio prende il microfono in un’assemblea di studenti e mormora il suo dolore di ex poliziotto che ha visto il massacro dei contadini di Avola, morti e feriti, e annuncia ribellioni tra gli agenti e la promessa di un sindacato di polizia. Magnifici gli attori (a parte qualche défaillances di personaggi secondari). (…)” (Mariuccia Ciotta, ‘Il Manifesto’, 10 settembre 2009)ita commuovente làdove intercetta la memoria personale di Placido, come quando Scamarcio prende il microfono in un’assemblea di studenti e mormora il suo dolore di ex poliziotto che ha visto il massacro dei contadini di Avola, morti e feriti, e annuncia ribellioni tra gli agenti e la promessa di un sindacato di polizia. Magnifici gli attori (a parte qualche défaillances di personaggi secondari). (…)” (Mariuccia Ciotta, ‘Il Manifesto’, 10 settembre 2009)
“Ladri di cene e biciclette, fricchettoni che si fanno fregare da supplì modificati, idealisti con molte idee ma confuse. La generazione di fenomeni che voleva cambiare il mondo come ce la racconta Placido, tra leader bellocci e parioline cattoborghesi, è lo stereotipo bohémienne della storiografia benpensante di chi allora represse. Il suo poliziotto ha qualche spunto in più (anche grazie a un bravo Scamarcio), ma sotto la divisa c’è poco e niente, né Pasolini né le guardie infami. Il film sembra un lungo trailer del ’68, incoerente nelle immagini e nella struttura narrativa, a cui manca Esmeralda Calabria (montatrice e, non a caso, anche regista) che salvò ‘Romanzo criminale’ dai tagli draconiani che subì. Qui le ellissi- si parla di tre quarti d’ora sacrificati- e gli errori, in alcuni casi anche tecnici, sono sconcertanti: Valle Giulia lascia il posto a un’estate borghese, i passi cruciali della conversione dell’attore-sbirro Scamarcio (che interpreta Placido stesso) sono affidati all’immaginazione, il materiale di repertorio e il bianco e nero che ‘invecchia’ le immagini del film sono lì a darci un Bignami retorico e improbabile della rivoluzione mancata. A un certo punto sembra di essere in ‘Baarìa’ (come Scianna, Argentero è stato in Russia e non ha trovato il comunismo, Avola ricalca le lotte di Tornatore) e il melò sentimental-politico è servito. ‘Romanzo popolare e politico’ l’ha definito il regista, e se così è si tratta di feuilleton d’appendice. E pure sgrammaticato. Si salva la colonna sonora, ma quello è merito dei geni di allora. Un grande incubo.” (Boris Sollazzo, ‘Liberazione’, 10 settembre 2009)ne, il materiale di repertorio e il bianco e nero che ‘invecchia’ le immagini del film sono lì a darci un Bignami retorico e improbabile della rivoluzione mancata. A un certo punto sembra di essere in ‘Baarìa’ (come Scianna, Argentero è stato in Russia e non ha trovato il comunismo, Avola ricalca le lotte di Tornatore) e il melò sentimental-politico è servito. ‘Romanzo popolare e politico’ l’ha definito il regista, e se così è si tratta di feuilleton d’appendice. E pure sgrammaticato. Si salva la colonna sonora, ma quello è merito dei geni di allora. Un grande incubo.” (Boris Sollazzo, ‘Liberazione’, 10 settembre 2009)
“Ovviamente ci sono gli scontri e ci sono le occupazioni, i genitori che non capiscono più i loro figli, i figli che non capiscono più i loro genitori, la borghesia corrotta e la borghesia codina… Come un accelerato, ‘Il grande sogno’ non si risparmia una fermata, ogni stazione è una celebrazione. Non sorprende che, avendo visto nella sala delle conferenze stampa Mario Capanna, Placido abbia ceduto al piacere di averlo accanto: narcisismo e retorica vanno sempre di pari passo. Non sorprende nemmeno che il film sia stato prodotto dall’odiata Medusa, ma Placido, purtroppo per lui, non è Giuseppe Tornatore, a cui in fondo si perdona tutto, persino il fatto che il suo ‘Baarìa’ sia piaciuto all’infame Berlusconi.”(Stelio Solinas, ‘Il Giornale’, 10 settembre 2009)
“Per crederci bisogna accettare uno sguardo caricaturale, nonostante le buone intenzioni. Salta, cioè, la misura della dimensione storica a favore di una catena leziosa di apici drammatici. Che autobiografia è? Le battute, i costumi, le auto sono talmente perfetti che sono finti, cioè ‘funzionali’. Grava sul film uno sguardo che non sente il tempo. Visto che i ragazzi di oggi dicono che Nixon era uno spray usato negli anni ’50, è una bella opportunitàche nel film si citi la sua visita a Roma. Ma se vedono ‘Il grande sogno’? Diranno che il ’68 fu un periodo di sommosse nell’Italia del dopoguerra?” (Silvio Danese, ‘Quotidiano Nazionale’, 10 settembre 2009)
“L’opera definitiva sul ’68 italiano, e-magari l’apice della carriera registica dell’ex commissario Cattani, è un’opericciola così così, una specie di ‘bigino’ degli accadimenti sessantottini, senza una figura, un particolare che non sia risaputo e senza soprattutto quel minimo di prospettiva che è il minimo dovere di chi ritorna sull’argomento a quarant’anni di distanza (…) Adesso sappiamo un mucchio di cose che nel bailamme, non potevamo focalizzare. Non si può prendere la storia di un piccolo grande amore all’epoca del gran casino, e riproporcerla tale e quale. Anche un ‘Sapore di mare’ dei Vanzina non può ignorare il tempo che è passato, che i nostri sentimenti non sono più quelli di una volta, e neppure le illusioni. Per dirla tutta ‘Il grande sogno’ è un film insincero, la celebrazione di un periodo che il Michele ha vissuto solo di striscio e per pochi mesi. La prova che per l’attore regista la grande ribellione fu solo un incidente giovanile di percorso è data dal fatto che i capi della rivolta (in primis lo studente operaio di Luca Argentero) sono sfocati, figurette convenzionali. ” (Giorgio Carbone, ‘Libero’, 10 settembre 2009)volta (in primis lo studente operaio di Luca Argentero) sono sfocati, figurette convenzionali. ” (Giorgio Carbone, ‘Libero’, 10 settembre 2009)
Carico di suggestioni, è un film dentro al quale si avverte la faticosa ricerca di un equilibrio costata tempo, ripensamenti e rimaneggiamenti. Ma l’esito non soffre. Tra i tanti passaggi che si fanno felicemente parte per il tutto c’è il riferimento al Nuovo Olimpia, all’epoca cinemino al centro di Roma, tempio cinefilo e luogo di marchette: buio accogliente per pomiciare tra un Pudovkin e un Bergman e rifugio quando i cortei si mettevano male. E’ speciale virtù di Placido quella dell’uomo di spettacolo di grande istinto che tiene miracolosamente insieme l’intuito dell’attore e l’audacia del regista che non sempre centra il bersaglio, ma mai si accontenta.” (Paolo D’Agostini, ‘la Repubblica’, 10 settembre 2009)
“Placido ci regala un bel film, auto-assolutorio, perché del grande sogno si racconta il rem, perché tutto va per il meglio per i suoi protagonisti attivi. Cosa volete che sia lanciare una molotov se ti vengono ad arrestare mentre tuo padre sta morendo? Scamarcio è un efficace feticcio pasoliniano. Nella sua bellezza cupa e nella sua identitàsociale. E’ un figlio del popolo, sua madre è ancora una serva, racconta ai compagni di unirsi liberamente a loro dopo che ha lasciato i colleghi. All’estrazione popolare dei poliziotti, si contrappone la famiglia borghese, quella di Jasmine, che daràtre figli al movimento. Di ironia e fantasia, in realtà, ce ne è poca. E’ un film su come i figli della borghesia e un figlio del popolo realizzano i loro sogni grazie ad un’esperienza difficile.” (Luca Mastrantonio, ‘Il Riformista’, 10 settembre 2009)
“Si può pensare che il ’68 sia irriproducibile: o che ogni memoria di un clima diverso da quello attuale sia positiva e che quindi Michele Placido abbia fatto bene a dirigere ‘Il grande sogno’ con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca e Luca Argentero. Il film senza stile non è riuscito e andràforse bene in tv, a puntate.” (Lietta Tornabuoni, ‘La Stampa’, 10 settembre 2009)
“Placido da una parte segue i casi privati, disegnando spesso, anche con finezza, i caratteri dei singoli e le situazioni da cui emergono, da un’altra domina i momenti collettivi ricostruendo con mano salda quella contestazione studentesca scandita da un montaggio concitato e rapidissimo, mentre la fotografia spesso scura di Arnaldo Catinari riesce a evocarvi in mezzo, grazie anche alle musiche vivide di Nicola Piovani, dei climi resi, senza concessioni al facile. Gli interpreti vi corrispondono con adesione sincera; Riccardo Scamarcio, come alter ego di Placido, Jasmine Trinca, la studentessa. Luca Argentero, il capo della contestazione. Un trio di segni forti.” (Gian Luigi Rondi, ‘Il Tempo’, 10 settembre 2009)
– PREMIO MASTROIANNI ALLA MIGLIORE ATTRICE EMERGENTE (JASMINE TRINCA) ALLA 66MA MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA (2009).