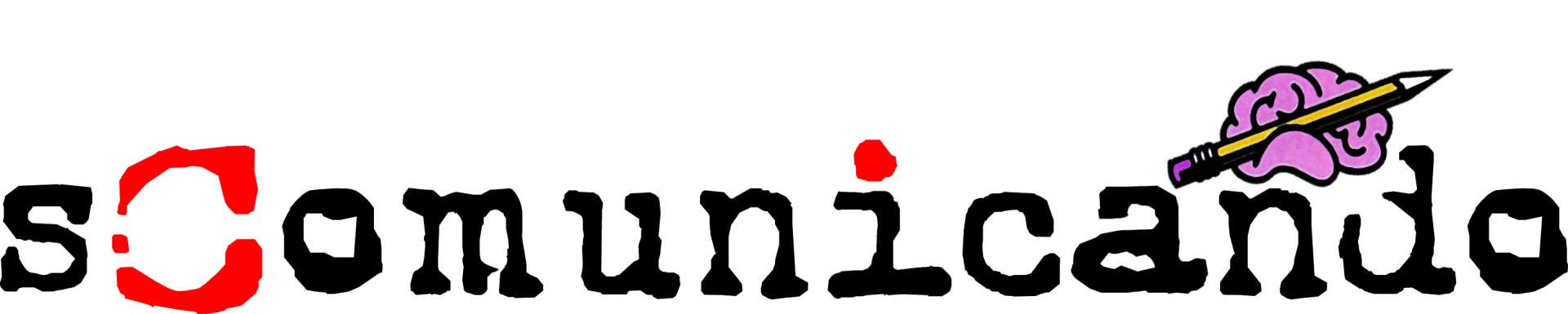di Antonio Mazzeo
di Antonio Mazzeo
 Le crisi economiche, sociali e politiche generate dalla diffusione generalizzata delle politiche neoliberiste e la contemporanea crisi ideale e d’identità delle organizzazioni di massa della sinistra (partiti, sindacali, ecc.) – fenomeni che hanno segnato l’ultimo trentennio – non potevano non segnare la mission, i percorsi e l’agire delle Organizzazioni non governative (ONG). Sviluppatesi in buona parte tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 per ripensare i modelli di sviluppo, sostenere le lotte di liberazione nel Sud del mondo e svolgere opera di sensibilizzazione contro le feroci dittature al potere in Asia, Africa e America latina, sono veramente poche le ONG che oggi s’interrogano sugli scopi sempre meno “umanitari” dei donanti e cofinanziatori dei propri programmi e progetti nel Sud del mondo. Complice poi la sempre maggiore dipendenza dalle sempre più scarse risorse finanziarie dei soggetti pubblici (l’Unione Europea e, in Italia, la DGCS Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri), le ONG si sono lasciate trascinare dalle logiche e le strategie di riacquisizione dell’egemonia in alcune aree geografiche ritenute “prioritarie” dai donanti non per l’oggettiva gravità delle condizioni di vita delle popolazioni ma perché sempre più spesso caratterizzate da governi deboli o disponibili alla firma di accordi di “libero commercio” per perpetuare il saccheggio delle transnazionali.
Le crisi economiche, sociali e politiche generate dalla diffusione generalizzata delle politiche neoliberiste e la contemporanea crisi ideale e d’identità delle organizzazioni di massa della sinistra (partiti, sindacali, ecc.) – fenomeni che hanno segnato l’ultimo trentennio – non potevano non segnare la mission, i percorsi e l’agire delle Organizzazioni non governative (ONG). Sviluppatesi in buona parte tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 per ripensare i modelli di sviluppo, sostenere le lotte di liberazione nel Sud del mondo e svolgere opera di sensibilizzazione contro le feroci dittature al potere in Asia, Africa e America latina, sono veramente poche le ONG che oggi s’interrogano sugli scopi sempre meno “umanitari” dei donanti e cofinanziatori dei propri programmi e progetti nel Sud del mondo. Complice poi la sempre maggiore dipendenza dalle sempre più scarse risorse finanziarie dei soggetti pubblici (l’Unione Europea e, in Italia, la DGCS Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri), le ONG si sono lasciate trascinare dalle logiche e le strategie di riacquisizione dell’egemonia in alcune aree geografiche ritenute “prioritarie” dai donanti non per l’oggettiva gravità delle condizioni di vita delle popolazioni ma perché sempre più spesso caratterizzate da governi deboli o disponibili alla firma di accordi di “libero commercio” per perpetuare il saccheggio delle transnazionali.
Mentre all’interno delle ONG tende a scomparire qualsivoglia dibattito sull’origine dei finanziamenti e le reali finalità sociali, politiche ed economiche dei progetti e/o delle controparti locali, si fa sempre più affannosa la ricerca delle «opportunità» rappresentate dalla partnership strategica con il mondo del profit, banche, holding e imprese private in testa. Pecunia no olet e, di conseguenza, si assiste alla moltiplicazione di programmi d’intervento e “cooperazione” con la sponsorizzazione dei grandi gruppi finanziari ed industriali dall’assai discutibile responsabilità sociale ed etica (in Italia, perfino, il colosso petrolifero ENI o il gruppo Finmeccanica a capo del complesso militare industriale).
Lo scoppio delle cosiddette “guerre umanitarie” (in ex Jugoslavia, Kosovo, ecc.), il consolidamento della dottrina dell’intervento militare USA-NATO-UE, con o senza il pass del Consiglio di sicurezza dell’ONU per «ristabilire ovunque democrazia, sicurezza e legalità» (Afghanistan, Iraq, Somalia), la strumentalizzazione delle crisi alimentari e dei disastri sempre più impropriamente “naturali” per legittimare l’occupazione militare di regioni di rilevanza strategica (Sri Lanka, Filippine, Darfur e recentemente Haiti), hanno ulteriormente contribuito ad emarginare quasi totalmente i soggetti e le esperienze realmente democratici e con aspirazioni di trasformazione sociale, locali e internazionali. Si è reso vita difficile se non impossibile alle ONG che tentano d’intervenire in modo autonomo nei Paesi vittima di conflitto, grazie ad una vera e propria paramilitarizzazione degli “aiuti” e della “cooperazione”. Gli eserciti possono e devono fare tutto: bombardare e ricostruire, affamare e sfamare, assetare e dissetare, togliere e dare speranze. Gli organismi non governativi e le agenzie delle Nazioni Unite, se proprio vogliono, possono operare sempre e quando l’intervento sia compatibile e funzionale alle strategie militari ed economiche delle coalizioni occupanti e dei fedeli partner in loco, a condizione di accettare le scorte dei blindati e dei militari o di body guard privati.
Il governo italiano segue in maniera del tutto subalterna la visione di una “cooperazione allo sviluppo” funzionale alle logiche del mercato globale e della guerra “preventiva e permanente”. A metà novembre 2009, nel corso dell’ultima riunione annuale della DGCS, sono state formalizzate le linee guida del piano che sarà presto implementato: tagli sostanziali ai finanziamenti pubblici e dirottamento dei fondi a favore delle missioni delle forze armate all’estero; utilizzo di contributi di aziende e industrie private; ONG ed associazioni di volontariato sostituite preferibilmente da università e istituti di ricerca; sempre meno progetti a medio-lungo termine e priorità agli interventi d’emergenza nelle aree geografiche d’interesse per l’economia nazionale e rigorosamente sotto il controllo di Washington e della NATO. Non è casuale che Afghanistan e Pakistan assorbiranno buona parte delle scarsissime risorse destinate allo “sviluppo” nel 2010. Per l’Afghanistan, in particolare, è stato approvato un contributo di 4 milioni di euro che sarà gestito dal Fondo di ricostruzione della Banca Mondiale, a cui si aggiungerà un finanziamento di 667 mila euro per un programma di «formazione a distanza tramite la televisione Radio education». Per il Pakistan è stato approvato invece un credito d’aiuto di 20 milioni di euro per «l’inclusione sociale e l’occupazione nella provincia nord-occidentale di frontiera», iniziativa dai contorni assai ambigui a cui il governo italiano aveva già concesso un credito di 40 milioni nel luglio 2009.
Anche se non viene esplicitato nei documenti ufficiali, la tendenza è quella di giungere ad assegnare la pianificazione, direzione e realizzazione degli interventi direttamente a task-force “miste”, composte da militari e civili, riproducendo in scala minore quanto gli Stati Uniti d’America stanno sviluppando in Medio Oriente, Africa, America latina e Caraibi grazie alla partnership tra i comandi regionali delle forze armate e USAID, l’Agenzia federale per gli aiuti allo sviluppo. Il Mali è uno dei luoghi dove la Farnesina sta sperimentando il nuovo modello di cooperazione joint venture con ONG, militari, aziende, università pubbliche e strutture sanitarie private. Questo paese tra i più poveri e militarizzati del continente africano e principale partner degli Stati Uniti nella campagna contro il “terrorismo” e le organizzazioni islamiche radicali, è teatro di un’inedita “missione umanitaria” denominata Ridare la luce. Organizzata e realizzata dall’Associazione Fatebenefratelli per i Malati Lontani (AFMAL), dal Ministero Affari Esteri, dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Aeronautica militare e dall’Esercito italiano, la “missione” vede come sponsor l’industria militare Alenia Aeronautica (gruppo Finmeccanica), che ha pure sfruttato l’occasione per inviare in Mali il nuovo prototipo di velivolo da trasporto tattico C-27J “Spartan” nel tentativo di promuovere la sua vendita nel continente nero.
Secondo il capitano Erminio Englearo, addetto stampa dello Stato maggiore dell’Aeronautica, Ridare la luce ha come obiettivi «la cura delle popolazioni del deserto del Sahel dalle malattie della vista, lo svolgimento di operazioni di chirurgia generale e lo scambio di conoscenze su nuove tecniche operatorie tra medici e infermieri italiani e maliani». Molto più esplicito sulle reali finalità della massiccia presenza militare nella missione è però il generale Vincenzo Camporini, Capo di Stato maggiore della difesa, giunto in Mali nel novembre 2009 insieme ai vertici della Direzione Generale per la Cooperazione. «Considero questo genere di attività – ha dichiarato – parte integrante dello scopo di una forza armata perchè ridurre il disagio sociale nelle zone dove può radicarsi il terrorismo è funzionale alla prevenzione di conflitti». Vecchio assunto teorico-strategico quello di Camporini, oggetto di analisi nei manuali anti-guerriglia delle truppe francesi in Algeria, dei berretti verdi in Vietnam, degli agenti CIA e dei “consiglieri militari” statunitensi ospiti delle dittature dell’America latina negli anni ’60, ’70 e ’80. Oggi è tema di approfondimento dei corsi destinati agli ufficiali africani che il Comando delle forze armate degli Stati Uniti per l’Africa (AFRICOM) organizza con sempre più frequenza in tutto il continente. AFRICOM, tenta infatti di rendere digeribile la politica di penetrazione strategica degli Stati Uniti in Africa alternando le esercitazioni militari e la fornitura di sistemi d’arma con microinterventi sanitari a favore delle popolazioni locali.
L’interventismo militare nel continente è stato giustificato prima dall’amministrazione Bush e poi da quella Obama con buona parte delle cosiddette “minacce” utilizzate per le operazioni di guerra in Medio Oriente: il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’espansione del fondamentalismo islamico, la difesa degli interessi economici (accesso all’energia), il narcotraffico, ecc.. Si fa però sempre più enfasi (si leggano in proposito le dichiarazioni del generale James Jones, Comandante supremo alleato in Europa SACEUR, rese davanti al Congresso USA nel settembre del 2006) all’esigenza di intervenire a 360 gradi, contro il «contrabbando, la pirateria marittima e la pesca illegale»; per arginare i «crescenti flussi migratori» e perfino per lottare contro la «fame, i disastri ambientali, la tratta delle persone e le principali epidemie» che affliggono il continente. “Minacce” dunque che mescolano insieme, esemplificandoli, fenomeni notevolmente complessi. L’Africa si trasforma di conseguenza nel laboratorio sperimentale per l’implementazione dello strumento militare-civile “umanitario”: è stato fatto da Washington prima con le operazioni in Mozambico, Sierra Leone, Repubblica Democratica del Congo ed Uganda, successivamente in Darfur e Somalia. E in alcune di queste “missioni” ipocritamente definite di «peacekeeping» o di «sostegno alimentare e sanitario delle popolazioni», il Pentagono è riuscito a coinvolgere la Forza d’Intervento Rapido (NRF) costituita dalla NATO, utilizzata alternativamente nelle operazioni di guerra in Afghanistan e in alcune gravi emergenze per calamità (l’uragano Katrina a New Orleans, il terremoto in Pakistan ed Haiti, ecc.).
La modalità con cui gli Stati Uniti stanno portando a termine questo pericolosissimo programma di emarginazione della società civile nei teatri più “caldi” del pianeta, traspare dalle parole di Theresa Whelan, assistente del Dipartimento della Difesa per gli affari africani. Riferendosi alle nuove “minacce” che pongono agli Stati Uniti il «dovere di intervenire nel continente» (letteralmente AIDS, malaria, tubercolosi e trasformazioni demografiche), Whelan ha dichiarato che il Comando militare USA in Africa deve «combinare funzioni militari e civili»; per questo è composto da «esperti nel campo dell’intelligence, della diplomazia, della sanità e dell’aiuto umanitario provenienti dal Dipartimento di Stato, dai Dipartimenti alla salute, ai servizi sociali e all’energia, da USAID». «AFRICOM – ha aggiunto l’assistente – coordinerà gruppi di addestramento, consulenza, affari civili, aiuto medico e veterinario. Esso farà da interfaccia con altre agenzie governative e gruppi umanitari non-governativi negli sforzi da portare avanti nel continente». Ancora più esplicito il generale James Jones, secondo cui «AFRICOM ha come priorità quello di aumentare la capacità delle nazioni africane nel condurre operazioni di mantenimento della pace e di pronto intervento in caso di crisi, particolarmente attraverso l’Unione Africana ed altre organizzazioni regionali, di proteggere le risorse naturali e di promuovere la stabilità fornendo consulenza ed assistenza sanitaria sui temi quali l’AIDS, il colera, la malaria e le altre malattie che hanno conseguenze umanitarie e strategiche».
Le finalità dichiaratamente neoliberiste della “cooperazione” USA, nell’ottica dell’accelerazione dei processi di privatizzazione globale delle risorse naturali e dei servizi (sanità, educazione, ecc.), sono state sottolineate dalla responsabile di USAID per l’Africa, Katherine Almquist, in occasione di un vertice militari-civili tenutosi presso il Comando AFRICOM di Stoccarda, il 17 ottobre 2008. «Abbiamo consulenti tecnici distaccati presso il Combined Joint Task Force-Horn of Africa a Gibuti, per operare in partnership con le forze amate a favore della promozione della sicurezza della nostra nazione e dei nostri alleati in Africa», ha affermato Almquist. «Gli Stati Uniti hanno giustamente identificato lo sviluppo come una componente integrale della propria sicurezza nazionale. Il Presidente della Banca Mondiale, Robert Zoellick, in un suo recente intervento, ha identificato le sfide maggiormente critiche negli Stati che si caratterizzano per la loro fragilità, cioè quelle riguardanti la governance, l’economia e la sicurezza, elementi strettamente collegati tra loro. Noi dobbiamo prendere seriamente in considerazione l’appello di Zoellick per una differente struttura che costruisca la sicurezza, la legalità, la governance e l’economia, aldilà di come intendiamo oggi la sicurezza o lo sviluppo. Zoellick utilizza l’espressione “securing development” per sottolineare la nozione di simultaneità nell’indirizzo a favore della sicurezza e dello sviluppo durante la fase di transizione dal conflitto alla pace e, successivamente, della stabilità affinché lo sviluppo possa affermarsi. Così noi di USAID applaudiamo agli interventi dei militari USA nel continente africano, in particolare alle operazioni realizzate a fianco dello loro controparti in Ghana, Senegal, Benin, Botswana e Kenya, preparando i militari delle nazioni africane ad affrontare le pesantissime sfide del 21° secolo in settori come il controterrorismo, la lotta al narcotraffico, gli interventi di peacekeeping e la sicurezza marittima (ossia la cosiddetta “lotta alla pirateria” NdA)».
Più specificatamente dal punto di vista della “cooperazione”, viene segnalato il complesso piano infrastrutturale finanziato e coordinato da USAID e dal Comando AFRICOM, e realizzato nella regione sub-sahariana dagli uomini dell’US Army Engineers, il corpo d’ingegneria dell’esercito statunitense. Attualmente sono in via di esecuzione 44 progetti nelle regioni più remote del Mali e del Niger: si tratta della costruzione di 32 pozzi d’acqua, 7 scuole, 2 piccoli presidi sanitari e 2 “banche di sementi”, costo totale 1,7 milioni di dollari. «Questi progetti beneficeranno gli abitanti, i nomadi Tuareg e i Wodaabe», ha affermato Darrell Cullins, responsabile progetti in Africa del distretto europeo dell’US Army Engineers. Per «promuovere la libertà economica ed investire sul capitale umano», il Mali è stato inoltre inserito dal Dipartimento di Stato tra i paesi del cosiddetto Millennium Challenge Account, il piano di «riduzione della povertà e di promozione della crescita economica a livello internazionale» avviato nel 2004. Sono previsti interventi per 461 milioni di dollari, finalizzati in particolare all’irrigazione di un’area di 15.000 ettari per la produzione di riso e all’installazione di attrezzature nell’aeroporto internazionale di Bamako per il trasferimento dei prodotti ai mercati esteri. Accanto allo sviluppo delle monoculture per l’esportazione, USAID sta inoltre incoraggiando le «politiche di alleggerimento dello Stato nell’economia», promuovendo i programmi di privatizzazione dei servizi e lo smantellamento di molte grandi imprese statali.
L’intervento di Washington non si fermerà tuttavia alle regioni sub-sahariane. «Per il futuro lavoro nel continente – ha aggiunto Darrell Cullin – l’US Army Enginners ha firmato un Multiple Award Task Order Contract (MATOC) che prevede il design e i lavori di realizzazione e manutenzione d’infrastrutture e di servizi destinati alla popolazione africana, per cui è prevista una spesa di 14,8 milioni di dollari entro il settembre del 2011. Il MATOC opererà principalmente in Niger, Ciad, Mali, Senegal, Marocco, Mauritania, Tunisia, Gabon, Ghana, Nigeria e Liberia, con la collaborazione dei militari presenti in Corno d’Africa e dell’US Navy». Cooperazione, dunque, sempre più mercificata e militarizzata.
Dato che anche la “sicurezza” non deve sfuggire alle regole del mercato “globale”, specie a partire dall’attacco USA e NATO in Afghanistan ed Iraq, società contractor e mercenari sono chiamati ad assumere un ruolo sempre maggiori nelle operazioni belliche e negli interventi “umanitari”. Per restare in Africa, è alla tristemente nota DynCorp che il Pentagono ha assegnato l’addestramento, l’equipaggiamento e il sostegno logistico della fallimentare “missione di pace” dell’Unione Africana in Somalia. L’amministrazione Bush ha versato alla società della Virginia, più di 10 milioni di dollari per l’acquisto di tende, generatori e veicoli da destinare alla peacekeeping force, e per garantire la movimentazione dei mezzi e del personale militare africano. Il Pentagono ha poi sottoscritto con DynCorp un contratto per oltre 20 milioni di dollari per il supporto alle «operazioni di sorveglianza, addestramento e peacekeeping» di alcuni importanti partner regionali (principalmente Etiopia e Liberia).
Ancora più sfacciato quanto USAID in collaborazione con l’agenzia per le Nazioni Unite per la lotta alla droga e al Crimine UNDOC sta implementando in Colombia, paese leader della crociata USA contro i governi progressisti della regione andina e dei Carabi. Nel paese sotto assedio del narco-paramilitarismo, USAID e UNDOC hanno stretto un’alleanza con la Casino Global Sourcing, azienda locale della transnazionale “Casino” che possiede la catena di supermercati ‘Exito’ (quelli nazionalizzati da Chávez in Venezuela), per promuovere una serie di programmi di «aiuto a favore dei campesinos colombiani» in vista dell’incremento delle produzioni e del loro posizionamento nei punti vendita “Casino” in Colombia e all’estero. Secondo quanto pubblicato dalla stampa colombiana, lo scorso anno il Grupo Casino ha esportato 1.360.000 chili di banane e 1,2 milioni di chili di gamberi, per un totale di circa 5 milioni di dollari. Per il 2010, si spera di triplicare il valore delle esportazioni e di diversificare ulteriormente la tipologia dei prodotti.
Peccato che molte delle piccole e medie imprese di campesinos siano sorte solo dopo il varo nel 2005 della cosiddetta “Ley de Justicia y Paz”, voluta da Alvaro Uribe per favorire la smobilitazione delle maggiori organizzazioni paramilitari. All’impunità per i gravi crimini commessi si è cosi aggiunta la possibilità di accedere ad ingenti contributi finanziari internazionali e, oggi, anche alla grande distribuzione. Senza che ciò abbia assolutamente rappresentato lo smantellamento delle paramilizie e una pur minima riduzione dei massacri della popolazione civile e delle comunità indigene e dell’omicidio selettivo o della sparizione forzata di leader comunitari e sindacali. Violazioni inaudite dei diritti umani che Washington continua a voler ignorare. Agli aiuti di USAID si aggiungeranno le centinaia di milioni di dollari del Pentagono per creare 7 nuove basi aeree in Colombia. Ancora una volta la politica del bastone e della carota.
Pubblicato in Guerre & Pace n. 158, aprile-maggio 2010.
Per ulteriori approfondimenti http://antoniomazzeoblog.blogspot.com/