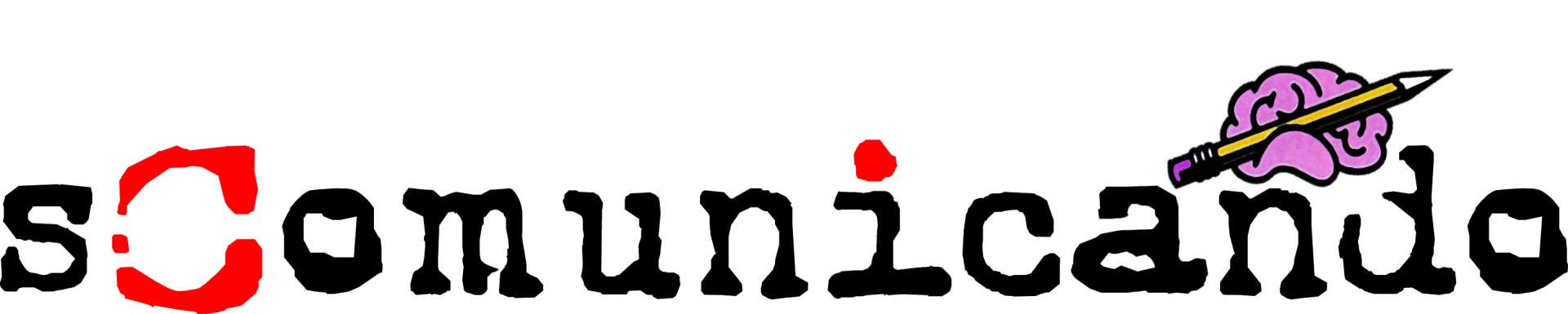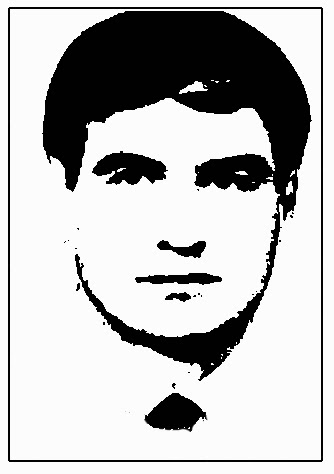Roger Coudroy è un nome nel vento, un’ombra che da cinquant’anni percorre le fantasie di chi almeno una volta ha sognato di lasciare ogni cosa alle spalle e vivere la pienezza di un ideale. Del primo caduto europeo in terra palestinese noi non conosciamo altro che la leggenda postuma, o quasi.
Si sa che fu un ingegnere belga cresciuto in Francia, che lavorò per la Peugeot in Kuwait prima di unirsi alla resistenza palestinese, che aveva 33 anni al momento della morte, sopraggiunta il 3 giugno 1968.
Nemmeno l’avvento di Internet ha dissipato la coltre di oblio che ne circonda il ricordo. Basti dire che di lui si trovano una sola fotografia e una manciata di riferimenti su Google, perlopiù in francese e in italiano. Come ha ricordato Giorgio Ballario nel ritratto più completo dedicato al militante di Jeune Europe, comparso proprio su Barbadillo, non esistono memoriali né testimonianze da parte di altri combattenti di Al Fatah o di familiari e compagni di fede politica che ne ricordino la figura.
La fama di Coudroy è così andata incontro a un destino singolare: ignorato per ragioni di opportunità dalla galassia dei gruppi di solidarietà con la Palestina, da sempre egemonizzata a sinistra, ha scontato a destra la difficoltà di instaurare su questo eroe sconosciuto un culto della memoria simile a quelli che l’ambiente ha prodotto in innumerevoli altri casi. Nessun presente, per il camerata Coudroy.
A pesare di più in questo senso è probabilmente la parabola della formazione di cui faceva parte, interrottasi solo pochi mesi dopo la sua morte. Jeune Europe rimarrà un’esperienza unica nel suo genere, quella di un movimento transnazionale che in nome del patriottismo europeo invita a far piazza pulita dei nostalgismi e a sostenere le lotte di liberazione del Terzo Mondo in chiave antiamericana e antisovietica.
Il belga Jean Thiriart, fondatore dell’organizzazione, giunge addirittura a vagheggiare un improbabile sostegno militare alla causa palestinese, da concretizzarsi con la formazione di “brigate europee” di volontari pronti ad accorrere tra il Mediterraneo e il Giordano così come era accaduto in Spagna nel 1936. Thiriart ne parla ai dirigenti dell’Olp con cui è in contatto, propone l’idea ai baathisti in Iraq e al presidente egiziano Nasser cui fa visita in quel fatidico 1968. Non troverà alcun seguito.
“Ho vissuto la resistenza palestinese”. Un testamento politico
Roger Coudroy intanto ha già incontrato il suo destino. A testimonianza dei pochi mesi da lui trascorsi nelle file della resistenza resta un breviario, a metà fra il diario personale e il saggio storico, dove il giovane ingegnere annota i resoconti delle sue esperienze e le sue vive impressioni sui combattenti palestinesi, ma anche alcune descrizioni molto intense sulle donne con “le guance dolci, il naso fine e le labbra tenere”, sui bambini dei campi profughi che “della Palestina ne fanno un’ode alla dolcezza che viene loro negata, al canto e alla fiducia, che li rende al contempo felici e senza speranza, in delle piccolissime tende bruciate dal sole e scosse dal vento, verso questo Paese fatto di latte e miele di cui hanno tanto sentito parlare e per il quale, forse, moriranno domani”.
Questo volumetto viene pubblicato a Beirut nel 1969 per opera del Centro Ricerche dell’Olp, con il titolo J’ai vécu la résistance palestinienne. Se ne conosce una traduzione tedesca, ormai altrettanto introvabile, denominata Widerstand in Palästina. In Italia solo pochi mesi fa una benemerita iniziativa della casa editrice Passaggio al Bosco ha finalmente consentito l’uscita di Ho vissuto la resistenza palestinese. Un militante nazionalrivoluzionario con i Fedayin.
Dopo i primi abboccamenti a Beirut con Al Fatah, il cammino dell’autore porta a Damasco, poi ad Amman, infine al campo profughi di Baqa’a dove Coudroy è divenuto il fedayin “As Saleh” (Il Giusto). Le ultime pagine, vergate dal 23 al 27 maggio 1968, riferiscono in modo sempre più scarno delle operazioni militari congiunte tra Al Asifah (l’ala militare di Fatah, di cui egli fa parte) e l’Olp. Poi il racconto si interrompe.
Ce n’è comunque abbastanza per cogliere qualcosa dell’uomo al di là del suo mito frammentario. Nelle pagine dell’opuscolo traspare il volontarismo che anima le sue scelte, la fiducia fin troppo ingenua in un prossimo rovesciamento di fronte all’indomani del disastro della guerra dei Sei Giorni: lo conforta l’esito della battaglia di Karamè, che nel marzo 1968 ha segnato una prima battuta d’arresto per gli israeliani.
Coudroy sa che la sua causa è giusta e tuttavia sa che essa non appartiene davvero a lui: “È vero che conosco il Paese e gli abitanti da quasi quattro anni, che parlo la loro lingua e che rispetto i loro costumi, che ho imparato a dire fin dall’inizio le parole più frequenti. Ma come si fa a far loro comprendere che nonostante la mia amicizia per gli uomini e la simpatia per la loro causa, io non ho dimenticato il mio Paese e la mia presenza non è del tutto disinteressata?”.
Il nemico canterà le nostre imprese
Non ci sarà tempo per rispondere a questi interrogativi. Nella notte del 3 giugno, a quasi un anno esatto di distanza dalla guerra dei Sei Giorni, un commando di Al Asifah tenta di penetrare in Palestina per una nuova operazione militare. Una pattuglia di Tsahal lo intercetta: tra le vittime dello scontro a fuoco c’è un giovane europeo, il cui corpo viene gettato in una fossa comune insieme a quelli degli altri fedayin e, per quanto è dato sapere, mai riesumato.
Sull’episodio in verità si avanzeranno illazioni infamanti. Un giornale inglese parla di una possibile esecuzione da parte degli stessi miliziani di Fatah, che lo avrebbero sospettato di essere un infiltrato del Mossad. Un’altra versione accredita l’ipotesi di un tragico incidente durante un’esercitazione.
A cinquant’anni di distanza, il nome di Roger Coudray resta per i pochi che ne conservano memoria la testimonianza di un sacrificio assoluto nel suo disinteresse. Nel silenzio che lo circonda, echeggiano le parole di un altro grande dimenticato come Jean Cau, autore con Il cavaliere, la morte e il diavolo di uno dei libri più straordinari del Novecento: “Se è vero che la causa è perduta questo significa, sì o no, che bisogna rinunciare a battersi per lei? Del resto, che vuol dire «causa perduta»? Quando tutto è perduto, si muore per una causa o per l’idea che questa morte ti dà di te stesso? Del resto, noi, «i vinti», avremo la nostra vittoria: un giorno, il nemico canterà le nostre imprese e si domanderà inquieto se la nostra morte, così alta, non è un segno, sotto uno sguardo eterno, della sua sconfitta. Penserà nel suo cuore: noi abbiamo bruciato le loro bandiere ma dov’è la nostra vittoria davanti alla loro ultima affermazione? «Sono fanatici». Davvero, sì. Sono usciti dal Tempio, la testa piena di oracoli, e sono stati travolti dallo zelo per il loro dio. Travolti: è la parola”.
«Non giocheranno più con i ragazzi, quegli agili, piccoli ragazzi arabi con gli occhi di velluto castano sulle loro teste tonde.
Non li vedranno più crescere nei campi di rifugiati, alla mercé della carità delle Nazioni Unite. Non li vedranno più seguire le lezioni di scrittura seduti per terra sotto le tende e non conosceranno più l’angoscia di vederli crescere, senza Patria, senza istruzione, senza spirito. E la sera, non siederanno più sulle terrazze delle pasticcerie per guardare le ragazze passare, fini e diritte sotto i veli bianchi e i lunghi abiti rossi o blu, la brocca sulla testa o i quaderni di scuola sotto il braccio.
Quando una pallottola o una baionetta li avrà colpiti, nel momento in cui saranno caduti – sanguinanti, bruciati e straziati – avranno gridato “Viva la Palestina” con uno slancio d’odio verso il nemico che avrà resistito una volta di troppo, un’ultima volta. O hanno pensato alla famiglia che li aspetta, in casa o sotto una tenda, alla fidanzata fiera e un po’ spaventata, alla madre che prega mentre il figlio muore sulla sabbia.
O magari hanno sorriso, immaginando il proprio volto sui manifesti?»
Roger Coudroy, “Ho vissuto la resistenza palestinese. Un militante nazionalrivoluzionario con i Fedayin”
A Ibrahim Abu Thurayeh, Fadi Abu Saleh, Razan Najjar, e tutti coloro il cui nome fu scritto sull’acqua